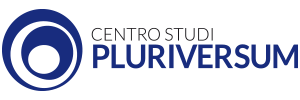L’Unione europea ha delineato obiettivi fondamentali per i sistemi dell’education degli Stati membri, e raccomanda e definisce da tempo azioni e priorità di intervento, enfatizzando l’importanza di avere approcci integrati, risorse territoriali, disponibili ed accessibili a studenti, genitori e famiglie.
Per rispondere a bisogni sempre più complessi, il sistema dell’apprendimento permanente ha a che fare con percorsi educativi tradizionali e modalità di micro-apprendimento, immediate, modulari e adattabili. Le persone dovranno sviluppare competenze trasversali per gestire carriere che alternano momenti di lavoro, formazione e riorientamento, avvalendosi di risorse per una lifelong guidance.
L’orientamento è una azione strategica affidata alle Regioni sin dal Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, che stabilisce il conferimento di funzioni alle Regioni in materia di orientamento, oltre al processo di riforma del Titolo V della Costituzione (2001) che ridefinendo le competenze concorrenti fra Stato e Regioni, attribuisce alle Regioni competenza esclusiva in materia di formazione professionale. Tale indicazione viene rafforzata, chiarendo ulteriormente il ruolo delle Regioni nell’orientamento dalla Nota MIUR n. 4232 del 19 febbraio 2014 (Linee guida nazionali per l’orientamento permanente).
I sistemi locali si trovano quindi a dover rispondere alle esigenze dei cittadini, in uno scenario mutevole, e che impone una valutazione ed un monitoraggio costante delle azioni.
Recentemente è stata pubblicata la nuova analisi dell’INAPP intitolata “L’offerta di orientamento in Italia – una mappa aggiornata dei servizi” (https://oa.inapp.gov.it/server/api/core/bitstreams/ebe0448c-8374-4f2f-b2b6-4f61e6c51e3a/content). Il rapporto solleva domande cruciali:
i sistemi di orientamento attualmente presenti e operanti nelle varie fasi dei percorsi di transizione dei giovani sono adeguatamente attrezzati ad agire in un contesto complesso?
Hanno gli strumenti e le competenze a far sì che un giovane sia sostenuto nelle scelte e nella conoscenza delle nuove opportunità̀ che rapidamente vengono a determinarsi?
Sono in grado i diversi contesti (educativo, formativo e occupazionale) in cui operano i servizi di orientamento a fornire informazione e supporto sui percorsi formativi e tendenze attuali del mercato del lavoro, sulle sfide che gli individui devono affrontare nella pianificazione della propria carriera?
Per rispondere a queste domande, l’analisi ha esaminato in ambito universitario, scolastico, formativo-professionale e lavorativo quattro aree tematiche fondamentali:
Caratteristiche organizzative: struttura e modalità operative dei servizi di orientamento;
Attività svolte: azioni e ruoli specifici degli attori coinvolti;
Competenze degli operatori: qualifiche, competenze e percezione dell’efficacia delle attività;
Utenza: profili demografici ed esigenze dei fruitori dei servizi.
Il documento ci offre nelle quattro sezioni principali una visione complessiva dell’attuale offerta di orientamento, riconoscendone i progressi in termini di organizzazione e innovazione, evidenziando anche le criticità ancora da affrontare per rendere tali servizi davvero efficaci e diffusi in tutto il territorio nazionale.
Il rapporto evidenzia come l’offerta di orientamento in Italia si stia evolvendo per fronteggiare le trasformazioni del mercato del lavoro e i cambiamenti nelle dinamiche educative. Tra i principali sviluppi si segnalano:
Un impegno rinnovato di atenei e istituzioni scolastiche per facilitare la transizione scuola-università e università-lavoro, attraverso servizi di job placement, tutoraggio e iniziative per prevenire l’abbandono degli studi.
L’introduzione di strumenti digitali e piattaforme online, che rendono i servizi più accessibili e interattivi.
L’ampliamento dell’offerta, con il passaggio da attività prevalentemente informative a interventi strutturati e continuativi.
Il contributo di iniziative normative e finanziamenti attuali (come quelli derivanti dal PNRR) che stimolano pratiche integrate e la creazione di reti tra enti pubblici e privati.
Quest’ultimo punto è particolarmente evidente, anche nella nostra pratica professionale. Spesso interveniamo in realtà territoriali con azioni di assistenza tecnica per armonizzare, rispetto ad una metodologia coerente e una analisi dei bisogni e degli obiettivi, le occasioni e offerte di orientamento presenti in un territorio. Non sempre notiamo la presenza di politiche di governance efficaci; sempre in riferimento al nostro paese coesistono modelli territoriali basati su un forte coordinamento centrale, e altri dove è evidente un’azione circoscritta a singoli territori. Naturalmente vediamo dei vantaggi e dei rischi: la prossimità con i territori permette di progettare azioni e accogliere proposte forse più vicine ai destinatari, che potrebbe perdersi a livello centrale. Allo stesso tempo un sistema di orientamento regionale dà una coerenza alle azioni attraverso chiavi metodologiche condivise e rende sinergico l’apporto della rete degli attori.
Va detto che la spinta riscontrata dal Inapp riferita al rinnovato impegno (primo e secondo punto) è probabilmente sostenuto da iniziative collegate al PNRR e segnatamente per ciò che riguarda la scuola il DM n.328 del 22/12/2022).
Anche dal nostro punto di vista le offerte territoriali, spesso ricche, risentono di attenzione non constante al posizionamento, all’accessibilità, alla differenziazione e alla qualificazione.
Punto nodale rimangono le competenze degli operatori in relazione ad uno standard definito. Molto spesso anche nelle nostre attività formative riscontriamo una necessità preliminare, data l’eterogeneità delle esperienze e delle provenienze disciplinari di quanti si occupano di orientamento, di definire i confini metodologici ed operativi per poi arrivare all’avvio di un percorso formativo.
Se a livello metodologico esiste una letteratura consolidata, a livello operativo, di posizionamento, di ostensione di obiettivi, la forte eterogeneità territoriale rischia di trasformarsi in una difficoltà per i potenziali destinatari di accedere ai servizi in maniera congrua.
Il rapporto a nostro avviso fa intuire l’esigenza una visione integrata che colleghi in modo più organico i vari livelli di intervento, evidenziando una frammentazione nelle modalità operative e nelle funzioni dei diversi servizi.
Dal nostro osservatorio, ovvero come società di professionisti che supportano i sistemi locali nell’implementazione di logiche di sistema, strumenti e metodologie, possiamo senz’altro confermare il valore delle sfide poste e riscontrare una volontà di costruire sistemi che offrano maggiore integrazione e che siano in grado di raccogliere le sfide poste. Nelle nostre pratiche di assistenza tecnica ai sistemi cerchiamo di cogliere la visione della committenza, e definire quale concezione di orientamento (che rischia in alcune situazioni di diventare un termine ombrello dove far ricadere l’offerta esistente) si vorrebbe adottare.
L’orientamento deve focalizzarsi sui bisogni individuali, richiedendo una qualificazione degli operatori e un’assistenza tecnica costante in grado di assicurare continuità alla verifica degli standard e dei modelli di erogazione dei servizi per garantire a tutti i cittadini accessibilità, trasparenza, pari opportunità, efficacia e qualità delle prestazioni e delle risorse orientative.
Oggi, fare orientamento significa supportare le persone nella costruzione delle competenze necessarie per costruire il loro percorso scolastici, formativo e professionale, individuando i punti di caduta dei bisogni e potenziandone i servizi a disposizione.
Nelle regioni in cui abbiamo operato attraverso azioni di assistenza tecnica conduciamo un lavoro capillare di sensibilizzazione degli attori della rete, cercando di cogliere, attraverso occasioni di progettazione partecipata, le rappresentazioni condivise della rete stessa, dei destinatari, degli attori in gioco, per costruire un modello di governance regionale. L’esito di queste azioni è, solitamente, la definizione da parte delle amministrazioni regionali di linee guida, oltre alla messa a sistema di strumenti dedicati.
In conclusione, riprendendo le sfide iniziali, l’impressione che ricaviamo è di un tessuto ricco e differenziato, che ha bisogno di una azione più decisa rispetto alle reti di soggetti che offrono sui territori occasioni di orientamento, al loro governo da parte di strutture sovraordinate, alla necessità di diffondere un profilo, senza intenti adempitivi ma di qualificazione del sistema.
Attraverso il nostro impegno su vari territori speriamo di poter contribuire, anche in minima parte, a questo disegno complesso e avvincente